L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato, con la delibera n. 96/25/CONS, le…
Gli avvocati verranno sostituiti dall’intelligenza artificiale?
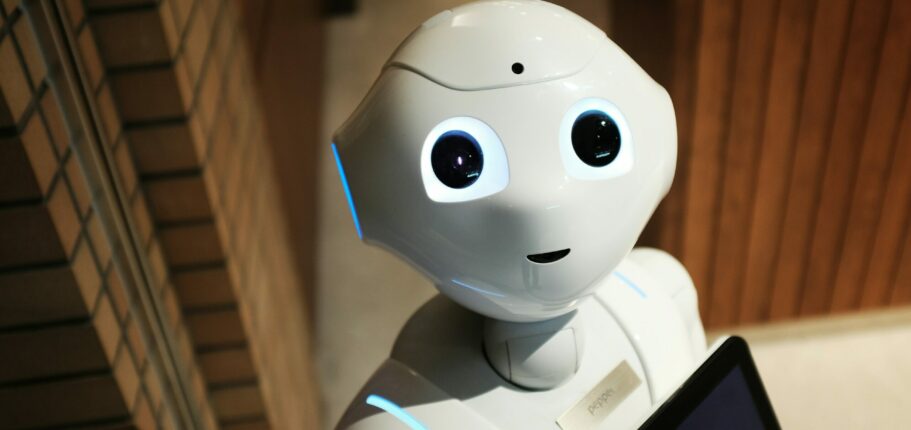
di Agostino Clemente
- Tecnologie disruptive: fare cose prima impossibili
C’è un libro fondamentale, di Clayton M. Christensen, pubblicato la prima volta nel 1996, “Il dilemma dell’innovatore”, che spiega l’impatto delle tecnologie dirompenti sulle attività economiche mature. Ci aiuta a capire come negli ultimi decenni abbiamo assistito alla progressiva scomparsa di interi modelli di business: Blockbuster ha ceduto il passo a Netflix, le enciclopedie cartacee a Wikipedia, le fotocamere digitali, ora integrate negli smartphone, hanno reso obsoleti dispositivi un tempo indispensabili.
Questi cambiamenti non si limitano a migliorare qualcosa di esistente, lo sostituiscono con qualcosa di completamente nuovo. Pensare che l’intelligenza artificiale serva solo per rendere più veloce ciò che già facciamo oggi è riduttivo, dunque è un errore. Dobbiamo invece chiederci: quali nuovi mondi possiamo costruire grazie a queste tecnologie? Quali opportunità inimmaginabili possiamo ora cogliere? Perché l’intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie dirompenti, ma forse più di tutte le altre, ci permetterà (e già ci permette, pur essendo soltanto all’inizio) di fare cose che, fino a ieri, erano semplicemente impossibili.
- Esempi: la telemedicina e l’innovazione nel settore legale
Prendiamo il caso della telemedicina. Se ci fermassimo all’idea che essa serve solo per effettuare visite a distanza, non comprenderemmo il suo vero potenziale. Oggi, grazie all’IA e ai dispositivi connessi, è possibile monitorare la salute di un paziente in tempo reale, raccogliere dati biometrici costanti, intervenire in modo preventivo e personalizzato. Questo significa prevenire malattie prima ancora che si manifestino, ridurre i ricoveri ospedalieri e garantire un’assistenza sanitaria più accessibile per tutti.
E nel settore legale? Oggi l’IA può analizzare una grande quantità di documenti e di sentenze in pochi secondi, e fornire supporto nella redazione di documenti giuridici complessi. Cose già straordinarie. Ma il vero effetto dirompente ci sarà quando ci consentirà di fare cose che oggi non riusciamo a fare: un giorno non si scriveranno più pareri lineari di 30 pagine o atti giudiziari di difficile digestione. Si realizzeranno, ad esempio, in pochi minuti pareri e memorie interattive, con collegamenti ipertestuali e magari anche contenuti audiovisivi. Lo so che sembra fantascienza ma qualcosa del genere è stato fatto proprio qui al tribunale di Milano da un giovane designer – Niccolò Parini – un paio di anni fa, con il favore dei giudici. Solo che in quel caso sono occorsi mesi di lavoro. Con l’intelligenza artificiale si farà in poche ore o pochi minuti.
- Le tecnologie devono incorporare i diritti
Tuttavia, ogni grande innovazione porta con sé anche nuove responsabilità. Non possiamo permettere che il progresso tecnologico proceda senza considerare l’etica e i diritti fondamentali delle persone.
Con il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il GDPR, venne introdotto un paradigma normativo: che le tecnologie devono essere progettate fin dall’inizio con la tutela dei diritti incorporata “by design”. Ciò significa che non basta regolamentare a posteriori, dobbiamo costruire un ecosistema digitale in cui la trasparenza, la privacy e l’accesso equo siano garantiti da subito. Questi principi oggi li troviamo anche nel regolamento sull’intelligenza artificiale e nel Global Digital Compact approvato a settembre dall’Assemblea dell’ONU.
Sotto un altro profilo, il rispetto dei diritti credo che sia necessario anche per evitare che l’innovazione venga rifiutata socialmente e politicamente. Pensiamo ancora alla medicina: il trattamento dei dati può davvero cambiare la nostra vita, e salvare le vite umane. E tuttavia, un trattamento selvaggio sarebbe estremamente pericoloso. Pensate che mondo sarebbe quello in cui i dettagli della nostra salute e della nostra vita privata fossero alla mercè di tutti; un mondo in cui chi sta male venisse discriminato sul lavoro o quando dovesse stipulare un mutuo o un’assicurazione.
Oppure pensiamo ad un mondo in cui le notizie vere e quelle false create artificialmente non fossero distinguibili. Un mondo in cui l’informazione fosse impunemente manipolata.
Dovrebbe essere chiaro a tutti che senza l’integrazione dei diritti nella tecnologia, questa diverrebbe prima o poi inaccettabile.
E allora vengo alla domanda: gli avvocati, i giudici, i medici verranno sostituiti dall’intelligenza artificiale? Rispondo facendo mio quanto ho letto tempo fa su Linkedin: gli avvocati, così come i medici, e un giorno anche i giudici, non verranno sostituiti dall’intelligenza artificiale, ma dagli avvocati, dai medici, dai giudici, che sapranno usarla.
- L’intelligenza artificiale cambierà il nostro modo di apprendere?
Noi siamo assuefatti ad una scuola e, soprattutto, ad una università in cui il modello educativo è leggere (o ascoltare) e ripetere. La risposta corretta agli esami è quella conforme alle attese del professore/giudicante. E’ un modello che abitua al conformismo, che censura la creatività. Ed è un modello sterile. Era sbagliato già prima, ma si diceva: bisogna prima imparare le nozioni e solo dopo si può essere creativi, si può fare ricerca, si può progettare, si possono risolvere problemi. E così via. Questo “dopo”, poi, spesso non arriva se non quando si entra nel mondo del lavoro, e solo per chi riesce ad emanciparsi da quell’approccio dogmatico-ripetitivo. Pensate che ancora oggi si diventa giudici superando un concorso in cui si fanno tre temi e si affronta un esame orale, con domande della commissione e risposte del candidato. È bravo chi fornisce le risposte “esatte”, non chi sa giudicare e interpretare il sistema normativo in relazione alle fattispecie che deve affrontare, non chi sa esaminare i fatti e capire le situazioni.
Questo era sbagliato prima. Ma ora diventa palesemente anacronistico, fuori della storia. L’intelligenza artificiale, quella generativa, collegata con i motori di ricerca e con imponenti banche dati, fornisce tutte le risposte, tutte le informazioni, o almeno pressoché tutte quelle che sono nei libri e sulla rete, in pochi secondi. Davvero pensiamo che la cultura consista nel competere con la macchina sul suo terreno?
Ciò che davvero serve oggi è la capacità di selezionare le informazioni in questo oceano di dati; identificare le risposte sbagliate; e poi scegliere, tra quelle non sbagliate oggettivamente, quelle che ci piacciono di più, perché più utili, o moralmente preferibili, o più eleganti, complete, semplici eccetera.
Ancor prima, per avere le risposte utili, bisogna imparare a porre le domande. 24 secoli dopo la morte di Socrate l’arte fondamentale è quella di porre le domande. Sono le domande che generano le risposte. Socrate la chiamava maieutica, oggi si chiama prompting, o prompt engineering. Si tratta delle tecniche per interrogare le macchine intelligenti e farle funzionare utilmente al nostro servizio.
Questo dobbiamo imparare, queste abilità dovrebbero essere insegnate ed apprese a scuola e all’università.
Come nel campo delle imprese, anche nell’educazione cambiano, cambieranno, totalmente i paradigmi. Non so con quanta velocità, ma chi non saprà cambiare l’approccio all’apprendimento resterà irrimediabilmente indietro.
Nei giorni scorsi, sempre su Linkedin, ho letto un’altra frase che pure mi ha colpito: “L’AI non sostituirà chi lavora; ma insegnerà a diventare diversi”. Io aggiungerei: “ci aiuterà a spendere più utilmente il nostro tempo, e a renderci più utili”.
- Quello che manca all’intelligenza artificiale
Quello che secondo me è più importante per utilizzare efficacemente l’intelligenza artificiale è proprio saper porre le domande. Per me, abituato a pormi un sacco di domande, e insofferente verso chi sfoggia certezze e assertività, è un invito a nozze.
E devo aggiungere: anche quando i dati finiranno — che poi, non so se finiranno davvero, anche perché ci sono anche i dati sintetici, quelli elaborati proprio dall’intelligenza artificiale, ma non solo per questo, insomma non lo so se davvero finirà il combustibile — una cosa è certa: non finiranno mai le domande!
Poi, certo, anche per porre le domande possiamo usare l’intelligenza artificiale. Adesso si sta imparando a utilizzarla anche per costruire domande migliori. Però, alla fine, quello che servirà sempre di più sarà la capacità di valutare e decidere. Quindi anche di selezionare le domande, oltre che le risposte.
Mi è stato chiesto: all’intelligenza artificiale mancherà l’ironia? Bella domanda.
Mi sono venute in mente due esperienze. Perché poi, chiaramente, uno se le pone, le domande. Giorni fa – in un seminario – abbiamo utilizzato Notebook LM: è uno strumento di intelligenza artificiale che lavora solo sulle fonti che gli vengono fornite dall’utente.
Allora, gli abbiamo dato in pasto contratti, leggi e altri documenti di carattere legale. Poi gli abbiamo chiesto se sapeva darci la ricetta della pasta alla carbonara. E lui ha risposto, ovviamente, che non la conosceva. Ha detto: “Non ho elementi per darti la ricetta della pasta alla carbonara”. Quindi uno pensa: “Vabbè, sei proprio una macchina. Ti sto prendendo in giro e non l’hai capito”.
Poi ho fatto un’altra esperienza. Ho chiesto sia a ChatGPT che a Copilot: “Che fine fanno le anatre di Central Park d’inverno, quando il lago diventa ghiacciato?”
E tutte e due hanno risposto subito: “Ah, la domanda di Holden Caulfield!” Hanno riconosciuto la citazione, hanno studiato. Hanno colto che era una domanda iconica. E poi hanno aggiunto: “La risposta comunque è che migrano, volano verso ambienti più caldi”.
E ChatGPT ha aggiunto: “Ma la vera domanda è: perché me lo chiedi?”
E lì sono rimasto strabiliato. Ho pensato: “Guarda, ha capito pure il sottotesto!”
Oggi ho provato ad andare oltre. Le ho chiesto: “Secondo te, perché te l’ho chiesto?”
E lì l’ho messa in difficoltà. Non ha saputo rispondere.
Ha dato una risposta di quelle che si danno quando non si è studiato bene per l’esame: ha tirato fuori un discorso generico su Holden, la crisi esistenziale, eccetera. Insomma, si è persa.
Infine, le ho chiesto anche: “Perché il tassista non sapeva rispondere a Holden?” E anche lì: niente. Non ha saputo rispondere. Ma imparerà, ne sono sicuro.
Ma perché non sapeva rispondere, il tassista?
Probabilmente perché noi siamo tutti un po’ assuefatti. Il tassista era così abituato all’idea che quell’animale stesse nell’acqua che, lì per lì, non ha pensato che ad un certo punto non fosse possibile. E forse pensava anche che fosse un pesce. In ogni caso, non si era mai posto il problema: era “assuefatto” a quella circostanza.
Quella domanda è iconica proprio per questo: perché sorprende che in pochi se la siano posta. Siamo abituati a pensare che, se un’anatra sta nell’acqua, allora lì rimane. E invece no: sono uccelli, migrano.
Ecco, anche qui vediamo nuovi paradigmi, nuovi modi di vedere, nuovi modi di pensare. L’intelligenza artificiale, secondo me, ci aiuterà anche a cambiare il nostro modo di pensare. Ma siamo noi che dobbiamo volerlo cambiare. Questo, l’intelligenza artificiale non ce lo regala.
In conclusione: le tecnologie dirompenti non sono semplicemente strumenti, sono opportunità per ripensare il nostro mondo. Ma dobbiamo decidere in che direzione vogliamo andare. Se ci limitiamo a piccoli aggiustamenti, non stiamo cogliendo il vero potenziale di queste innovazioni. Se invece usiamo la tecnologia per creare ciò che oggi non esiste, allora potremo davvero costruire un futuro migliore per tutti.








